 Si trova a Niederurnen, 60 Km a sud di Zurigo, la prima fabbrica di eternit dell’impero industriale degli Schmidheiny. E’ lì che a partire dagli anni ’60 è approdata l’emigrazione di circa un migliaio di leccesi del Capo di Leuca, insieme a tanti altri dal resto del sud. E’ da lì che molti son tornati con un mostro nei polmoni, che ha accorciato le loro vite e avvelenato gli ultimi anni di sopravvivenza. (1)
Si trova a Niederurnen, 60 Km a sud di Zurigo, la prima fabbrica di eternit dell’impero industriale degli Schmidheiny. E’ lì che a partire dagli anni ’60 è approdata l’emigrazione di circa un migliaio di leccesi del Capo di Leuca, insieme a tanti altri dal resto del sud. E’ da lì che molti son tornati con un mostro nei polmoni, che ha accorciato le loro vite e avvelenato gli ultimi anni di sopravvivenza. (1)
Delle loro condizioni di lavoro e di vita scrive Mario Desiati inTernitti (Eternit, nel dialetto del Capo): “C’era un uomo solo sulla passerella. Sotto fermentava il cemento e produceva nuvole grigie. Dal sipario di condensa e amianto avanzava a lunghi passi contro le colate. Una volta l’anno dalla passerella volava qualcuno e finiva nell’amianto bleu. Era una corsa rapida, ma pericolosa come solo poche cose. …… Nel reparto producevano tubi e lastre ondulate di cemento amianto. Il soffitto del capannone era alto affinché il fumo potesse disperdersi o almeno desse l’illusione di farlo . Decine di vasche accerchiavano il transetto su cui lavoravano uno dietro l’altro gli operai formando un carosello di gesti identici. Rastrellare, bagnare, setacciare, spartire e creare cumuli di materiale da plasmare. In ogni reparto c’era un tipo diverso di amianto … crisotilo, amosite, crocidolite.. Quest’ultimo conosciuto anche come amianto bleu, era il più pericoloso. Era usato per le mescole. Era quello che tutti là dentro, almeno per un attimo, avevano respirato e si erano scrollati dalle tute…… l’odore dell’impasto era insopportabile, pungente, gonfiava le narici ed entrava come aghi invisibili sotto il derma … Il naso alla fine della giornata sembrava una bietola, i capillari ribollivano … Ippazio ogni giorno lassù portava l’impasto della densità di una crema su dei teli di lino per filtrare l’acqua, il composto poi veniva versato nelle formelle per modellare i tubi e le lastre. Dopo aver deposto il cemento nelle forme, di solito Ippazio iniziava a tossire, una tosse che i primi mesi era solo una tosse da gola secca, ma col tempo diventò roca, con i bronchi sempre pieni di catarro. “Lat-te, lat-te, trinken latte” gridava una voce dall’intonazione teutonica … Dopo un anno di lavoro il fisico di Ippazio era cambiato e lo sviluppo del corpo si era fermato, i muscoli si erano induriti, la resistenza fisica era diminuita. I primi mesi riusciva a setacciare anche trenta, quaranta volte al giorno, col tempo a malapena una decina di volte. Il petto gli si indolenziva e la sera non riusciva a parlare. Antonio Orlando era stato ai sacchi, per alcuni mesi aveva lavorato coi contenitori di juta riempendoli di crocidolite, poi era passato ai taglieri ad acqua: lì fendeva con precisione i blocchi di cemento amianto. Operazione che faceva disperdere tantissima polvere, nonostante gli impianti di aspirazione tutte le oltre cento persone addette al reparto, al termine del lavoro tossivano come flagellate dalla bronchite, con la gola rauca”.
Come in Puglia, anche in Svizzera non mancavano i caporali, quelli che mantenevano l’ordine fra le varie comunità di emigrati (rigidamente divise per provenienza geografica), quelli che potevano escluderti dal lavoro o dal dormitorio, quelli che avevano il compito di starti addosso quando la malattia non ti permetteva più di mantenere i ritmi produttivi. Fuori dalla fabbrica e dalla sua fatica malsana prevaleva il freddo della “casa di vetro”, la vetreria abbandonata trasformata in accampamento. Un gelo che veniva dall’interno delle cose, entrava nelle ossa, spaccava le dita. Il resto era una quotidianità piena di squallore. Questo fino al ritorno a casa, al profumo del pomodoro fresco, alla partita a carte intorno a un tavolo, al lavoro nei campi, almeno finché la voce non iniziava ad affilarsi e a diventare un pigolio. Dopo qualche anno dal ritorno, per i reduci della “casa di vetro” cominciò il tempo delle “parmasie”, i cesti di pasta, zucchero, olio, pomodori secchi preparati per sostenere i parenti del morto dopo il funerale. “Per chi era morto di ternitti si aveva una cura speciale affinché la parmasia fosse priva di latte. Ne avevano bevuto sin troppo da giovani, gli aitanti operai che respiravano asbesto con il sogno di essere immuni al mal di petto”.
Ternitti è un romanzo ambivalente: rasenta la storia orale nel descrivere l’emigrazione, cade di credibilità nel ritorno a casa. Il Salento di Desiati è fintissimo, da cartolina. E’ quello che piace ai turisti, con i tuffi a lu ciolo, la festa di Santu Rocco e la pizzica tarantata, tanto incantevole che non si capisce nemmeno perché la gente sia emigrata, o continui ad emigrare. E’ una terra immaginaria dove le donne sessualmente libere vivono tranquille, senza stigma sociale (sarà, ma quelle che saccio ieu campano fiaccu, ma fiaccu devero), e i padroni cattivi sono solo quelli di fuori: gli svizzeri dell’Eternit, il manager di Roma che sposta all’estero la produzione del cravattificio. Non trovano posto nella narrazione le tredicenni che negli anni ’80 lavoravano nelle salentinissime dittarelle dei subappalti della Luisa Spagnoli per 300 mila lire al mese (‘che a 18 venivi licenziata perché “potevi pretendere”), o le operaie rimaste cieche per i collanti dei calzaturifici di Casarano, con le famiglie tenute zitte con 4 soldi, e nemmeno le braccianti agricole, che ancora oggi vanno in campagna senza stipendio, solo “per le marche” (i contributi per la disoccupazione). Non compare quel sodalizio mafioso/clientelare fra imprenditoria locale e potere politico a cui i salentini per decenni hanno dovuto sottomettersi, in cambio di lavori senza diritti, sicurezza e dignità (2). Non c’è nemmeno un rigo sugli artefici autoctoni della delocalizzazione industriale verso i Balcani … Sergio Adelchi … i Filograna. Insomma, “Ternitti” è un libro che a casa propria non disturba proprio nessuno.
Il libro: Mario Desiati, Ternitti, Mondadori, 2011, p. 258.
(1) Finora sono stati accertati 117 operai italiani morti o malati di mesoteliomi e tumori polmonari dopo avere prestato servizio nelle filiali svizzere della multinazionale dell’amianto. Per questi lavoratori la Procura di Torino sta aprendo una seconda fase del processo Eternit. Nel 2012 è partita la ricerca dei 967 operai salentini delle fabbriche di Schmidheiny da parte della Procura e dell’ Associazione emigranti esposti e familiari salentini vittime amianto Svizzera. La platea delle persone coinvolte è destinata ad ampliarsi, comprendendo le mogli che lavavano le tute e i familiari che respiravano le fibre portate a casa sui vestiti degli operai.
(2) Per capire qual era il “clima” nelle fabbriche salentine e il livello di complicità fra sistema imprenditoriale, potere politico, chiesa, magistratura, organi di controllo, è indicata la lettura della dispensa “La resistibile ascesa di Antonio Filograna”, oltre al libro di Luigi Renna, L’imprenditore padrone. Rapporto sulla repressione antisindacale nel Basso Salento, Milella, Lecce, 1986.
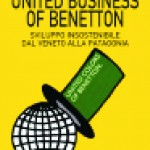 “Personalmente vedo complicato che le imprese comincino a preoccuparsi se le Leggi Nazionali di un Paese permettano una vita dignitosa ai lavoratori che lo abitano”. Carlo Landi, direttore della pubblicità del Gruppo Benetton (1999).
“Personalmente vedo complicato che le imprese comincino a preoccuparsi se le Leggi Nazionali di un Paese permettano una vita dignitosa ai lavoratori che lo abitano”. Carlo Landi, direttore della pubblicità del Gruppo Benetton (1999).







