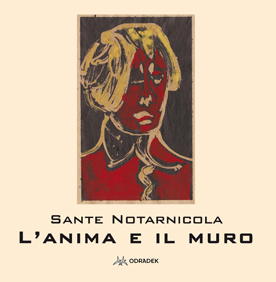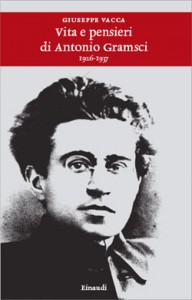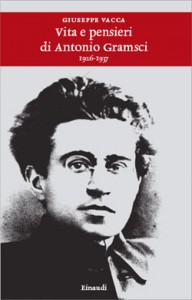
Bisogna che al Manifesto facciano pace col cervello: il fatto che riescano a recensire due volte lo stesso libro, prima stroncandolo e poi promuovendolo, è quantomeno bislacco. Così è per il libro di Giuseppe Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci 1926- 1937, Einaudi, 2012, XXII – 370 p., nel quale Giulio Ferroni (Alias 17/06/12) identifica non poche incongruenze, superficialità e imprecisioni.
Molto bella la recensione della Rossanda del 22/06, che riporto (visto che fra qualche giorno scomparirà dal sito del giornale).
Una storia aperta. SORVEGLIATO SPECIALE
Rossana Rossanda. I difficili rapporti e comunicazioni con il partito comunista dopo l’arresto, il ruolo di collegamento di Piero Sraffa e Tatiana Schucht, il regime di carcere duro, la rigida censura imposta dal fascismo. E la scelta, con i «Quaderni», di avviare un lavoro teorico per sottrarre il marxismo dalla vulgata in cui era caduto.
Con Vita e pensieri di Antonio Gramsci, 1926-1937 (sul volume è uscito un pezzo su «Alias libri» del 17 giugno) Giuseppe Vacca mette il punto, a venti anni di ricerche sue e di altri studiosi, su una biografia attraversata dalle vicende del Pcd’I, del partito comunista russo (Vkp) e dell’Internazionale Comunista dalla metà degli anni Venti alla seconda guerra mondiale. Biografia emersa lentamente e le cui zone di oscurità corrispondono a silenzi e sofferenze di un detenuto tormentato dal dubbio di essere condannato/abbandonato sia dal suo partito sia da chi gli era più caro. Alcune di queste oscurità perdurano in archivi russi non ancora accessibili, ma Vacca ne delinea perimetro e spessore con una cura che, quando arriveranno i documenti mancanti, ne uscirà confermato, penso, il percorso che egli propone.
Insopportabile solitudine
È un volume denso, fitto di riferimenti ai molti che hanno lavorato sui frammenti d’una storia ai quali Vacca rende merito, a costo di una lettura meno agevole per chi non è sempre in grado di rintracciarne le fonti. È costruito appunto attorno alle zone oscure, oltre a due interpretazioni dei Quaderni, attorno alla «revisione» gramsciana sui limiti della teoria e pratica della rivoluzione del ’17, lavoro che Gramsci s’era proposto fuer ewig, e aveva reso meno insopportabile la solitudine in cui si trovava. Non a caso la biografia non parte dalla giovinezza né da Torino, ma dal novembre del 1926 quando viene fermato e poi arrestato, nonostante l’immunità parlamentare, mentre si stava recando in una località della Valpolcevera, dove avrebbe dovuto discutere con gli altri membri del Comitato Centrale del Pcd’I e con Jules Humbert Droz, in rappresentanza dell’Internazionale, della lettera che aveva mandato due settimane prima a Togliatti, appunto per l’Esecutivo della Ic. Essa esprimeva un giudizio severo sull’esclusione di Trotskij; non che Gramsci ne condividesse le posizioni, anzi, ma per il danno al movimento comunista internazionale che avrebbe rappresentato la brutale rottura del gruppo leninista. Già si era scontrato, in una breve corrispondenza, con Togliatti. La riunione in Valpolcevera si fece e concluse senza di lui con il rientro nei ranghi del Pcd’I. Non ci furono biasimi per Gramsci; se e come l’Esecutivo della Ic ne abbia discusso a Mosca, è ancora precluso negli archivi. Che Gramsci restasse sospetto, se non di trotzkismo, di una troppo tiepida lotta al medesimo, è certo.
Inizialmente confinato a Ustica per cinque anni, dal 20 gennaio 1927 è trasferito a Milano, perché in quei giorni Mussolini toglie di mezzo ogni garanzia e istituisce il Tribunale speciale, con imputazioni pesanti e che si aggraveranno, a istruttoria già chiusa, per l’attentato dell’aprile alla Fiera di Milano. Tutto un susseguirsi di illegalità procedurali. Il rinvio a giudizio gli sarà consegnato nel carcere di San Vittore di Milano nel marzo del 1928 e nel giugno viene condannato, assieme a Terracini, Scoccimarro, Roveda e altri, a venti anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione. Viene assegnato al carcere di Turi. Ma è ancora in attesa del processo, quando riceve una lettera a firma di Ruggero Grieco, scritta da Basilea ma inoltrata via Mosca, che dà e chiede notizie, lo assicura che il partito gli è stato sempre vicino, «anche quando aveva meno ragione di sperarlo», lo informa dell’esclusione di Trotskij e finisce con un improbabile arrivederci. Gliela consegna il giudice istruttore Macis con una osservazione maliziosa: evidentemente al suo partito non dispiace che lei resti a lungo in galera.
L’originale della «strana» lettera non è accluso agli atti del processo. Alla morte di Antonio la prende Tatiana Schucht fra le carte di Nino – come lo chiama sempre – e la porta con sé a Mosca nel 1938. Paolo Spriano pensa di averne trovato la copia fotografica negli archivi dell’Ovra, ed è questa che è stata oggetto di grandi discussioni. A prima vista non è chiaro perché possa aggravare la posizione dell’imputato, ma Gramsci ne è certo. Per l’insinuazione del giudice Macis? Così pensa Peppino Fiori, e penserà Piero Sraffa. Ma Antonio, che con Macis ha lunghe conversazioni, lo ritiene persona corretta e amichevole. Vacca, che vi ha fatto un’indagine, conferma questo giudizio.
Una lettera da decifrare
Perché dunque la lettera sarebbe grave, Gramsci la definirà addirittura scellerata? Essa non rivela nulla alla Corte sull’importanza dell’imputato. Perché finisce con un arrivederci? Perché contiene, scrive più tardi Antonio, un trionfante «gliela abbiamo fatta»? Chi l’avrebbe fatta e a chi? Vacca ritiene che le prime parole di Grieco alludano a un tentativo di liberazione attraverso uno scambio di detenuti, che secondo Gramsci avrebbe irritato Mussolini per non essere stato negoziato esclusivamente tra stati e quindi andato a monte. Ad un inesperto vien da pensare che invece quel sottinteso «gliela abbiamo fatta» che fa infuriare Gramsci si riferisca a Trotskij e quindi a Gramsci in quanto contrario alla sua esclusione, ma è una pura elucubrazione.
Sta di fatto che Gramsci non cesserà di arrovellarsi. Tanto più che non la crede iniziativa del solo Grieco, ma suggerita dall’alto. Da Togliatti? Non può verificare, perché nei nove anni che seguiranno, non potrà scrivere né ricevere lettere senza che siano censurate, né ricevere alcuno che non sia «parente» – cioè la cognata Tatiana Schucht, più raramente i fratelli Carlo e Nannaro, e un solo amico, Piero Sraffa, l’economista cattedratico a Cambridge, nipote d’un senatore fascista che è anche Primo presidente della Corte di Cassazione, Mariano d’Amelio. Può scrivere una lettera ogni quindici giorni, più tardi ogni settimana, quindi una volta ai suoi a Ghilarza e un’altra a Tatiana, incaricata di provvedere alle sue (poche) necessità e a smistarne le notizie alla moglie Giulia a Mosca e a Piero Sraffa. Il quale, passando da Parigi, ne informa il Centro estero del Partito comunista d’Italia.
È in una rete a maglie assai strette. Se a questa incomunicazione obbligata si aggiungono le speranze messe nei tentativi di essere liberato attraverso uno scambio di prigionieri fra Urss e Vaticano, Urss e governo italiano, che a Gramsci sembrano delinearsi ma non si realizzano mai per qualche imprudenza o omissione che attribuisce ai compagni italiani, la frustrazione e la collera sono grandi. E traspaiono dalle lettere, spesso ingenerose, a Tatiana.
Di più, nel 1929, la Ic svolta su una linea che Togliatti sposa «con zelo»: il fascismo sarebbe prossimo al crollo, la socialdemocrazia ne è uno strumento, la rivoluzione torna imminente, classe contro classe. Antonio spiega ai «politici» che sono a Turi con lui che invece il fascismo si stabilizza e non si possa che lavorare a un fronte antifascista sulla parola d’ordine della «assemblea costituente». Ma quasi tutti i compagni si allineano con il partito. Gramsci non è d’accordo neanche sull’espulsione di Leonetti, Tresso, Ravazzoli. Ne viene una divisione acerba, della quale riferisce Athos Lisa (Rinascita, 1964). Isolamento e amarezza.
Messaggi in codice
Siamo ai primissimi Anni Trenta. Antonio, che all’inizio della carcerazione si sentiva in buona forma, ha avuto nel 1927 l’attacco d’un antico male e sta sempre peggio, le lettere da casa si fanno rade, gli è nascosta la morte della madre e non capisce perché gli scriva così poco da Mosca l’amata Giulia, che non sa quanto e di che sia malata. A forza di proteggere il carcerato, Tatiana sbaglia. Lei stessa ha una salute fragile a volte non lo può visitare. Gramsci si sente in mano di altri che decidono per lui, senza capire che cosa questo diventi per un detenuto e teme di venir inaridito lui stesso dall’altrui indifferenza. Allude per la prima volta, scrivendo a Giulia, al «doppio carcere» cui si sente condannato, dal fascismo e da una parte dei suoi – lei stessa, lo spirito «ginevrino» degli Schucht? Forse il suo stesso partito? Non può spiegarsi, è appena più esplicito scrivendo poco dopo a Tatiana. La lucidità, il dolore assieme alla nettezza della scrittura colpiscono l’opinione fin dalla prima edizione delle «Lettere», assai censurata, del 1947. Si sforza di leggere, di imparare altre lingue, tradurre, e scrive. Saranno di quegli anni i trenta grandi quaderni in grafia minuta, in un linguaggio in parte criptico per eludere la censura in parte innovativo rispetto alla vulgata marxista. Del primo saggio su Croce, con il quale propone di fare i conti come Marx con Hegel, offre qualche elemento di codice per Togliatti.
Il trasferimento, sempre più malato, a una clinica di Formia (deve pagare le sbarre da mettere alla sua camera) dove Tatiana può venire più facilmente a trovarlo, interrompe la loro corrispondenza. Né Tatiana né Piero Sraffa lasceranno però che cosa egli abbia pensato degli anni che vanno da allora alla sua morte. Nel 1933 Hitler ha preso il potere in Germania, nel 1934 Stalin prende a pretesto l’uccisione di Kirov per schiaccare le opposizioni, nel 1935 il VII congresso rovescia la linea del ’29, ma lontano dalle implicazioni della critica che al ’29 muoveva Gramsci, nel 1936 Franco aggredisce la repubblica spagnola, il Giappone ha moltiplicato gli attacchi alla Cina – la seconda guerra mondiale è alle porte. Con Tatiana, anche senza testimoni, Gramsci può non averne parlato, ma con Sraffa?
Domande in attesa di risposta
Restano alcune lettere per Giulia, strazianti. Le chiede di raggiungerlo, Giulia non può, non ce la fa, la famiglia glielo impedisce, o l’Nkvd (Ministero per gli affari interni). Gramsci pensa di lasciare la clinica e riparare in solitudine a Santu Lussurgiu, in attesa che venga il permesso di espatriare in Urss, se può venire. Ma è colpito da un’emorragia cerebrale il giorno stesso in cui la sua pena si estingue e muore poche ore dopo. È il 27 aprile del 1937.
Che sarebbe stato di lui se fosse rimasto in vita? Con il precipitare della situazione internazionale, altro che espatrio, e in quella solitudine affettiva? E così ammalato? Vacca esclude che, da alcune righe a Giulia, si possa dedurre che considerasse chiusa per sé la politica. Ma in quali condizioni e dove? Su questo non possiamo che riflettere, non abbiamo elementi e forse non è nemmeno utile.
Vacca lavora sul destino del suo lascito scritto, specie i Quaderni. Tania li ha portati all’ambasciata sovietica che li deve inoltrare a Giulia. Appena incontra Sraffa, poco dopo la morte di Antonio, gli mostra la «strana» lettera e gli dice che Nino avrebbe voluto un’inchiesta. Sraffa legge, non ne è impressionato, le consiglia di andare a Parigi e parlarne con Grieco. Con il firmatario sospetto? Tania è indignata; per poco non cessano i loro rapporti Non andrà affatto a Parigi, tornando a Mosca nel 1938 se ne occuperà lei stessa assieme alle sorelle. Neanche i Quaderni devono finire nelle mani di Togliatti, che in quel momento è in Spagna: li trascriveranno da sole loro tre, le Schucht. Ma Togliatti, che ne conosce qualche frammento in fotocopia speditogli a Barcellona, sa da Sraffa come Antonio li voleva pubblicati, li reclama per il Pcd’I.
Comincia allora una lotta non sotterranea con le Schucht, nessun accordo con loro è realmente raggiunto, le tre si rivolgono a Ezov, capo della Nkvd, con la quale sia Genia sia Giulia hanno un rapporto di dipendenti/sorvegliate. Ma Ezov è destituito, si rivolgono a Stalin che le rinvia a Dimitrov, il quale manda il tutto in corner. Togliatti è già sotto inchiesta, per altri motivi, su denuncia del partito spagnolo. L’Ic, in via di scioglimento, affida le carte di Gramsci a una commissione di cui fa parte Togliatti. La guerra arriverà alle porte di Mosca, altri sono i problemi, non penso che sia da scervellarsi tanto sul perché il proposito delle sorelle fallisca. Tania morirà durante la guerra. Da parte degli Schucht, un lavoro sulle carte di famiglia sarà intrapreso soltanto da un Antonio, nipote di Antonio, come nella famiglia sarda da Mimma Paulesu.
Vacca dà alcune sobrie notizie sull’ambiente degli Schucht, piccola nobiltà decaduta, un patriarca bolscevico, una madre intellettuale ebrea. E dei rapporti delle tre sorelle con Gramsci: Genia, la più militante, è quella che ha conosciuto e forse amato prima di conoscere Julca, che è il suo grande amore vero. Genia non glielo perdonerà mai, lo definirà «talpa malvagia». Tania gli ha dedicato dieci anni, ma non si scopre nei sentimenti. Nessuno degli Schucht è abituato a parlare con verità di se stesso e con la famiglia. La più libera, Tania, ne era fuggita. Gli Schucht sono un esempio vivente dell’intreccio che Gramsci scorge fra grande e piccola storia, politica e cultura, individuo.
Non credo che su questo ci sia da discutere. Ma dal lavoro di Vacca vengono molti interrogativi. Non soltanto sulla «strana» lettera, ma sul rapporto fra Gramsci e Togliatti e viceversa. Se Antonio ne diffidava tanto da sospettarne un atto «scellerato», perché è a lui che gli preme di far pervenire il codice delle pagine su Croce? E attraverso Sraffa, che sa in contatto con Togliatti, dà indicazioni di lavoro sui Quaderni? Togliatti non lo ha, più che perseguito, protetto? Nel modo come ha protetto se stesso, come si è protetto Dimitrov, il cui curioso Diario non fa parola di Gramsci? Non opponendosi mai a Stalin per salvarsi o per salvare un domani il loro partito? Gramsci l’intransigente, Togliatti il politico disposto a tutto?
Un’aspra concreta realtà
Anche su Stalin viene da farsi più di una domanda, e non solo per il punto che oggi ci riguarda. Nel ’40 un suo agente, Mercader, uccide Trotzki, che è lontano, in Messico, ma dell’eresia italiana non gli interessa. Togliatti ne è investito non poco; perché Stalin lo chiama al Cominform – un fantasma – e perché la direzione del Pci glielo spedirebbe volentieri? E perché Gramsci, ha ragione Vacca, resta fedele al Vkp, cioè a Stalin, pur essendo il più severo critico del suo «marxismo leninismo»? Forse perché pensava l’Urss come la sola «concreta realtà» del movimento comunista? E fin dove è andato il «revisionismo» gramsciano quando ha cessato di scrivere? Vacca pensa molto avanti, legge i Quaderni anch’egli fuer ewig. Togliatti però li pubblica – censura soprattutto le Lettere – sapendo che l’Urss e gli altri partiti comunisti non si inganneranno – nessuno di essi, a quanto so, li riprende. E negli ultimissimi anni non nascondeva che bisognava aprire qualche breccia nel non detto, processi inclusi, se si voleva salvare il salvabile.
I gruppi dirigenti che gli sono succeduti non lo hanno più fatto. Né dopo il 1964 né dopo il 1989. Per questi ultimi, Gramsci sembra «mai visto né conosciuto». È rimasto agli storici, molti, ma solo a loro. E non diversamente ha fatto, con l’eccezione di Alberto Burgio, la nuova sinistra. C’è da riflettere.
 Elton Kalica, La pena di morte viva. Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico, Meltemi, 2019, pp. 189.
Elton Kalica, La pena di morte viva. Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico, Meltemi, 2019, pp. 189.
 “Là, dov’era più umido
“Là, dov’era più umido